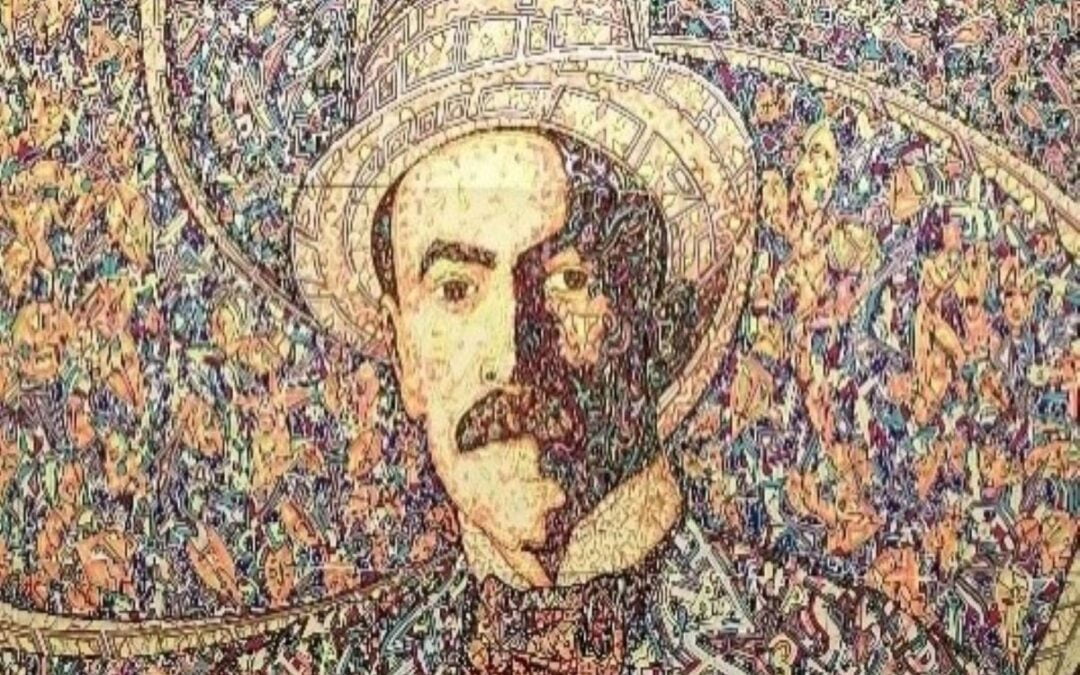
L’inetto ne La coscienza di Zeno e nell’oggi: forse non così distanti
L’inetto ne La coscienza di Zeno e nell’oggi: forse non così distanti
Scrive Italo Svevo nel 1927 a Valerio Jahier: “E perchè voler curare la nostra malattia? Davvero dobbiamo togliere all’umanità quello ch’essa ha di meglio?”. L’umanità è malata, ma di un male che è anche la sua ricchezza. Forse la soluzione non è la guarigione, ma l’accettazione stessa della malattia.
Esce nel 1923, quella che è considerabile come l’opera centrale della produzione di Italo Svevo, La coscienza di Zeno. Il romanzo, in forma di memoriale, è ascrivibile al genere del romanzo psicanalitico, in totale rottura rispetto all’impianto classico del romanzo ottocentesco.
L’opera si apre con una prefazione che avvisa il lettore sul fatto che quanto sta per leggere è la narrazione autobiografica di un tale Zeno Cosini, pubblicata per vendetta dal suo psicanalista, il Dottor S., dopo la decisione del paziente di interrompere la terapia.
La prefazione rende il romanzo molto più attuale di quanto potrebbe sembrare, infatti oggi più che mai la frequentazione di uno psicologo o psichiatra, non solo è una pratica non infrequente, ma per molti necessaria. Le ragioni si possono facilmente cogliere guardandosi attorno, la società attuale – come mai prima d’ora – sottopone i suoi componenti a prestazioni e ritmi altissimi, per via dei quali molti faticano a trovare il proprio posto e sono portati a sentirsi inadeguati.
Per via di tali ragioni, nel romanzo Zeno Cosini, ripercorrendo le tappe della propria storia personale e famigliare, tenta di recuperare (o forse acquisire) una “salute”, la cui mancanza gli rende impossibile l’integrazione nella società.
A colpire Zeno è una malattia alquanto particolare, quella che Svevo chiama “inettitudine”.
La figura dell’inetto, tipo letterario affermatosi a partire dalla trilogia di romanzi di Svevo, Una Vita, Senilità e La coscienza di Zeno, trova proprio in quest’ultimo una sua più piena maturazione e risoluzione.
L’inetto può essere definito come “uomo inadatto alla vita”, incapace di cogliere e godere di momenti significativi della propria esistenza. Vittima della propria condizione, delle propre debolezze e indecisioni, fatica ad adattarsi e trovare un posto nella società che lo circonda, a ogni tentativo di inserimento ottiene il risultato contrario: esclusione e fallimento. Questa condizione produce uno scarto tra propositi e obiettivi effettivamente raggiunti, così per esempio Zeno si propone tante volte di smettere di fumare, fallendo continuamente. A caratterizzare l’inetto è però una lucida consapevolezza di questa sua condizione, la stessa consapevolezza che porterà Zeno a chiedere supporto al Dottor S.
L’esito della terapia tuttavia, è ben diverso da quello atteso: Zeno Cosini potrà infatti dirsi guarito solo nel momento in cui deciderà di interrompere le cure.
Ha qui luogo un ribaltamento del rapporto sanità-malattia, che apre una riflessione estendibile all’oggi. Zeno è inizialmente mosso dal proposito di guarire dalla malattia-impossibilità di aderire ai valori della società, una società animata da un forte senso di fiducia nel progresso, certa del successo dell’uomo borghese ben inserito nei meccanismi sociali. Scopre invece che il vero sano è proprio lui, perché capace di mettersi in discussione, di intraprendere un’autoanalisi e di guardare con distacco ciò che lo circonda, svelando gli inganni dell’ipocrisia borghese. Zeno ha preso coscienza del fatto che la vita è inquinata sin dalle sue radici. Tale condizione appartiene a tutta l’umanità, certa di un sistema di valori destinato a fallire e per la quale l’unica soluzione possibile sembra essere l’annientamento totale del genere umano.
La conclusione di Svevo è netta: la società è malata e la vita dell’uomo è animata dall’incertezza e dall’insoddisfazione. Il vero malato è chi non è disposto ad accettare tali fragilità, ostinandosi a credere fideisticamente in un meccanismo destinato a non perdurare all’infinito. L’unica via d’uscita è allora l’accettazione.
Quelli che la società chiama “sani” sono uomini superficiali, inconsapevoli della propria condizione: uomini condannati a reprimere le proprie pulsioni e inclinazioni vitali, disposti a piegarsi a un alienante meccanismo sociale.
Zeno al contrario è un inetto destinato a vincere perché in grado di riflettere e accettare quella che è la condizione propria dell’essere umano.
E la condizione di Zeno, in fondo, non è poi così diversa da quella dell’uomo contemporaneo. E’ dalla metà dell’Ottocento che l’individuo si è trovato a fare i conti con una società sempre più pressante, competitiva, che lo sottopone a una costante prestazione di efficienza e produttività. La società industriale e arrivistica affermatasi dalla seconda Rivoluzione Industriale chiede all’individuo la cieca fede a un ideale di progresso destinato apparentemente a non fallire mai, nella convinzione, certezza e illusione di essere la via migliore e l’unica perseguibile. Zeno Cosini insegna che è possibile mettere in discussione questa concezione, che l’individuo moderno possiede gli strumenti per riflettere, comprendere e reagire ai meccanismi della realtà in cui è collocato. L’inedeguatezza, quella stessa che può portare a intraprendere un percorso di cura, talvolta può invece rivelarsi il sintomo di maggiori sensibilità e consapevolezza.
La vicenda di Zeno offre un monito, un invito a riflettere sulle imposizioni richieste dalla società anche al giorno d’oggi, uno sprone a non subirne passivamente le decisioni e a non rassegnarsi a una tacita accettazione. L’invito è a guardare con un certo distacco il mondo, a coglierne le imprecisioni e ad accogliere sé stessi come tali senza un totale autoannulamento, ma con una disponibilità a ritagliarsi uno spicchio di vita per sé, perseguendo le proprie inclinazioni, senza sentirsi colpevoli di non aderire a pieno agli ingranaggi dell’impositivo meccanismo sociale nei quali ci si trova a vivere.

Martina Tamengo
U. Eco una volta disse che leggere, è come aver vissuto cinquemila anni, un’immortalità all’indietro di tutti i personaggi nei quali ci si è imbattuti.
Scrivere per me è restituzione, condivisione di sè e riflessione sulla realtà. Io mi chiamo Martina e sono una studentessa di Lettere Moderne.
Leggo animata dal desiderio di poter riconoscere una parte di me, in tempi e luoghi che mi sono distanti. Scrivo mossa dalla fiducia nella possibilità di condividere temi, che servano da spunto di riflessione poiché trovo nella capacità di pensiero dell’uomo, un dono inestimabile che non varrebbe la pena sprecare.


