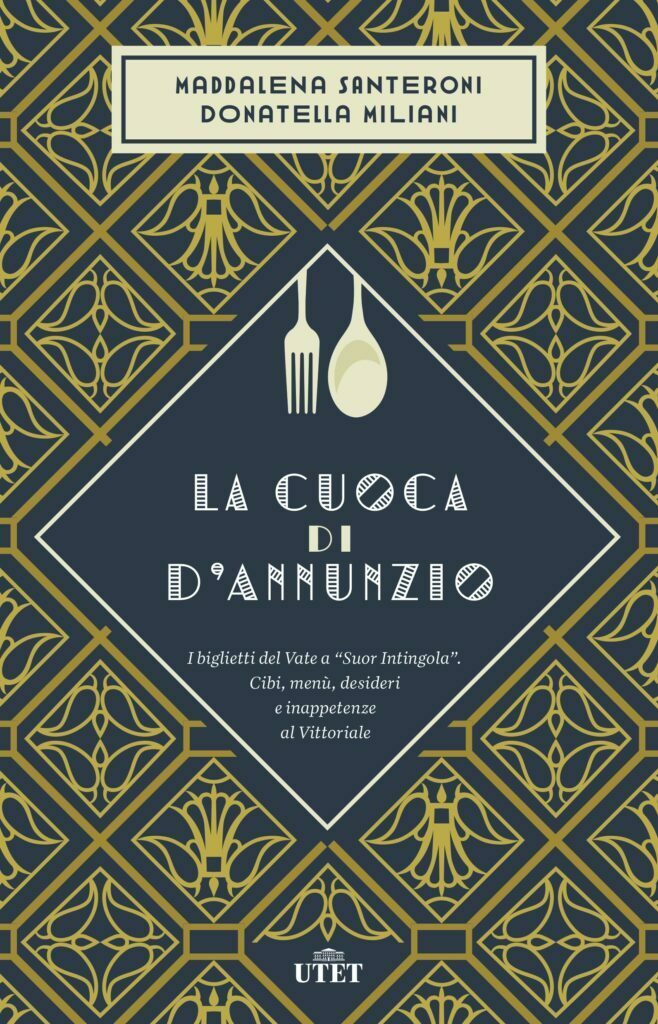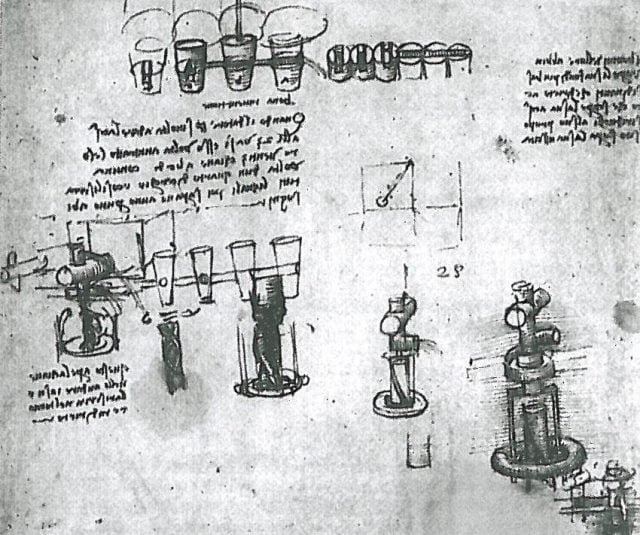Il male di vivere e perire con gusto ovvero Leopardi a tavola
Il male di vivere e perire con gusto ovvero Leopardi a tavola
Non è certo noto per la sua allegria o la vita mondana, ma Giacomo Leopardi sembra un’altra persona quando si parla di cibo. Se davvero siamo quello che mangiamo, come inquadrare la più brillante mente filosofica dell’Italia dell’Ottocento?
Sebbene Giacomo Leopardi non fosse proprio il manifesto della felicità e dell’ottimismo, non rinunciava ai piaceri del cibo. Scrisse nello Zibaldone a proposito del mangiare: “occupazione interessantissima la quale importa che sia fata bene, perché dalla buona digestione dipende in massima parte il benessere, il buono stato corporale, e quindi anche mentale e morale dell’uomo”. Frase che detta da chi ha elaborato i concetti di pessimismo storico e di pessimismo cosmico assume tutto un altro fascino.
Il suo rapporto con il cibo era di godimento e gusto. Scrisse infatti una lista di quarantanove pietanze che amava particolarmente, fra cui frittelle di riso, carciofi fritti nel burro, zucca fritta, pane dorato, cervelli fritti, ricotta fritta, pasta sfoglia, polpette, paste frolle, capellini al burro, pasticcini di maccheroni di grasso e di magro, bodin di latte, riso al burro, patate al burro, purè di fagioli, latte a bagnomaria, latte fritto. Sì, latte fritto. Che non è molto diverso dalla nostra crema fritta, o no?
La lista leopardiana serve da pretesto a Domenico Pasquariello e ad Antonio Tubelli, artista il primo e cuoco il secondo, per raccontare in un libro, seguendo il ritmo delle stagioni, le atmosfere e i sapori della Napoli del primo trentennio dell’Ottocento, in cui si collocano episodi e suggestioni relativi agli ultimi anni di vita di Giacomo. A conclusione venti ricette ispirate alla lista. Il volume, pubblicato nel 2008 e da poco ristampato, si chiama Leopardi a tavola ed è edito da Fausto Lupetti.

Non è che Leopardi mangiasse proprio sano, e avendo una salute cagionevole questo era un problema. Scorrendo l’elenco si nota che manca completamente la carne: non perché non l’amasse, ma perché l’elenco del poeta rispecchia alla perfezione quella che era la dieta dell’epoca. Un’alimentazione ricca di carboidrati, in cui le proteine derivavano principalmente dalle uova, dalle frattaglie, dai formaggi e in rari casi dal pesce.
Eravamo un popolo che consumava prevalentemente pane e vegetali, dove la carne faceva la sua comparsa (se la faceva) a domeniche alterne: nel primo decennio del Novecento il consumo di carne era di appena quindici chili pro capite all’anno, contro gli oltre duecento chili di pasta e pane. Negli anni del boom economico, improvvisamente, il consumo di proteine è salito in maniera esponenziale: la carne da un decennio all’altro – dagli anni Sessanta agli anni Ottanta – aumenta di ben venti chili pro capite.
Leopardi mangiava tantissimo gelato, tanto che sembra che non abbia voluto allontanarsi da Napoli durante il colera proprio per non rinunciare ai gelati di Vito Pinto alla Carità, famosissimo gelataio partenopeo dell’epoca. Inoltre beveva moltissimo caffè, zuccheratissimo, che amava sorseggiare ai tavoli del Caffè d’Italia in Piazza San Ferdinando. Era goloso, senza orari, capriccioso, e sembra che negli anni di Napoli sublimasse con il cibo gli altri piaceri che gli erano negati. Un po’ come noi fra marzo e maggio dell’anno scorso, quando blindati in casa senza possibilità di vedere i nostri affetti ci siamo lanciati su pacchi di patatine e barattoli di gelato.
Era malato, certo, ma Leopardi viveva una vita abbastanza disordinata, dormendo di giorno e svegliandosi solo nel tardo pomeriggio. Chiedeva che gli servissero la colazione al pomeriggio e il pranzo a un’ora variabile tra le dieci di sera e mezzanotte. Nonostante la salute, non seguiva le prescrizioni dei medici: se questi gli ordinavano di non mangiare carne, decideva immediatamente di “perire di pesci e di vegetali”. Quando invece gli prescrivono una dieta di grassi, non ne vuol più sapere di pesce e verdure, dichiarando allegramente di voler “perire” con l’abbuffarsi di lessi e col sorbire brodi densi come la panna.
E di cos’è morto Giacomino? Forse non di colera. Secondo uno studio del professor Cesaro, pare sia morto per aver mangiato un chilo di confetti. Inoltre, forse per attenuare gli effetti dell’indigestione, gli era stata data una tazza di brodo caldo di pollo e una limonata fredda: una miscela rivelatasi micidiale, che avrebbe provocato – in aggiunta – una congestione intestinale.
Vivere male, ma perire con gusto. In fondo, non è forse di dolciumi che avremmo tutti voluto morire da bambini?
di Gaia Rossetti

Gaia Rossetti
Sono una gastrocuriosa e sarò un'antropologa.
Mia nonna dice che sono anche bella e intelligente, il problema è che ho un ego gigantesco. Parlo di cibo il 60% del tempo, il restante 40% lo passo a coccolare cagnetti e a far lievitare cose.
Su questi schermi mi occupo di cultura del cibo e letteratura ed esprimo solo giudizi non richiesti.